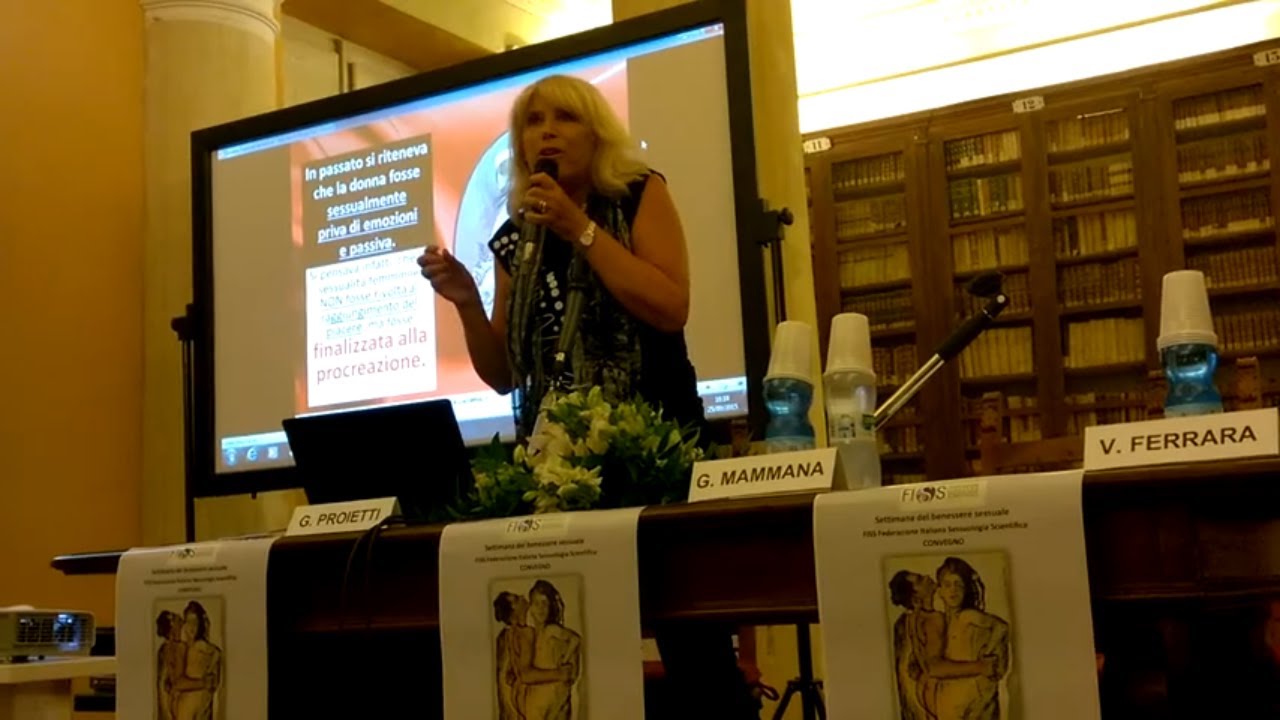Periodo refrattario Post-Eiaculatorio e Effetto Coolidge
Dr. Giuliana Proietti - Contatti
Cosa è il periodo refrattario e come è stato scoperto?
Alcuni studi condotti sui ratti maschi hanno mostrato che, dopo l’accoppiamento, vi era un periodo immediato in cui i ratti non venivano eccitati dalla presenza di una femmina ricettiva accessibile e che doveva trascorrere un certo lasso di tempo prima che potessero tornare ad essere sessualmente attivi. Questo intervallo di tempo è stato chiamato periodo refrattario.
Cosa è l’effetto Coolidge?
Se, nella situazione precedente, veniva introdotta una nuova femmina ricettiva, il ratto maschio riprendeva l’attività sessuale con lei. Questo fenomeno divenne noto come “Effetto Coolidge”, in riferimento a un aneddoto attribuito al Presidente Calvin Coolidge e a sua moglie durante una visita a un allevamento di polli alla fine degli anni ’20. Si racconta che la Signora Coolidge chiese alla guida con quale frequenza i galli svolgessero il loro “dovere”. La guida rispose: “Decine di volte”. Lei allora disse: “Per favore, riferitelo al Presidente”.
Quando il Presidente Coolidge venne informato della straordinaria performance dei galli, chiese se fosse sempre con la stessa gallina. Saputo che ogni volta si trattava di una gallina diversa, rispose: “Per favore, riferitelo alla Signora Coolidge”.
Anche se la storia è apocrifa, riassume in modo divertente e memorabile il comportamento sessuale maschile. I maschi di molte specie hanno un forte impulso a cercare varietà nei propri partner sessuali, una strategia evolutiva che aumenta la diffusione dei loro geni.
Intervista - Come salvare un rapporto di coppia
Dr. Giuliana Proietti - Psicoterapeuta Sessuologa
L’Effetto Coolidge esiste anche fra gli esseri umani?
Non si sa. Negli esseri umani, non è eticamente realistico verificare in modo univoco l’effetto Coolidge, attraverso osservazione diretta o esperimenti. Oltre ai resoconti aneddotici, dobbiamo affidarci a dati o attività indirette per indicarne la possibile presenza. Tra le evidenze indirette della sua esistenza negli esseri umani troviamo:
- La significativa riduzione dell’attività sessuale tra coniugi dopo circa due anni di matrimonio o convivenza;
- Il maggiore interesse degli uomini rispetto alle donne nella varietà dei partner sessuali;
- La presunta riduzione comune del periodo refrattario e l’aumento dell’eccitabilità che gli uomini più anziani possono sperimentare con una nuova partner;
- Nella valutazione dei volti, sia uomini che donne preferiscono la familiarità nei volti maschili, ma nel caso dei volti femminili gli uomini tendono a preferire tratti meno familiari rispetto alle donne, suggerendo che gli uomini siano più inclini alla novità nei partner sessuali.
Dagli studi di laboratorio a breve termine, inoltre, sappiamo che l’abitudine si verifica sia negli uomini che nelle donne quando scenari erotici vengono ripetuti regolarmente, portando alla perdita di eccitazione sessuale. Tuttavia, questo effetto è più marcato negli uomini rispetto alle donne. Resta ancora da determinare per quanto tempo duri questo effetto (se sia a breve o a lungo termine).
In che cosa consiste il periodo refrattario?
Per quanto riguarda il periodo refrattario, la sua suddivisione in una fase assoluta e relativa era già nota negli studi sulla trasmissione degli impulsi lungo una fibra nervosa. Dopo che un potenziale d’azione ha attraversato l’assone, un secondo impulso non può essere trasmesso fino a quando non è trascorso un certo periodo di tempo, indipendentemente dall’intensità dello stimolo (tempo refrattario assoluto). Tuttavia, successivamente, vi è un intervallo in cui un secondo potenziale d’azione può essere generato e trasmesso se lo stimolo è più forte rispetto a quello iniziale (tempo refrattario relativo).
Questi concetti di base sono stati applicati allo stato eiaculatorio nei ratti. Il tempo refrattario assoluto corrispondeva al periodo successivo all’eiaculazione in cui il maschio era completamente insensibile a qualsiasi stimolo sessuale. Tuttavia, con il passare del tempo, diveniva possibile stimolare nuovamente il maschio nella fase tardiva del periodo refrattario, purché lo stimolo fosse più intenso o nuovo (ovvero, con una nuova femmina ricettiva). Questa seconda fase del periodo refrattario fu denominata tempo refrattario relativo.
Lezione sui Social Media
Sono stati condotti studi sul periodo refrattario negli uomini?
È sorprendente notare che, nonostante l’esistenza del periodo refrattario sia ben documentata nei roditori e in altri animali da oltre 80 anni, gli studi su questo fenomeno negli esseri umani siano stati piuttosto limitati. Questo è particolarmente curioso considerando l’attenzione dedicata al trattamento dell’eiaculazione precoce. Una migliore comprensione del meccanismo del Tempo Refrattario Post-Eiaculatorio (PERT) potrebbe infatti facilitare la nostra conoscenza del controllo dell’eiaculazione.
Quando è stato utilizzato per la prima volta il concetto di Tempo Refrattario Post-Eiaculatorio Assoluto e Relativo?
La suddivisione del periodo refrattario dopo l’eiaculazione in una fase assoluta e una relativa fu utilizzata per la prima volta per descrivere lo stato sessuale dei ratti negli studi di Beach e Holz-Tucker [1949]. Successivamente, l’esistenza di uno stato inibitorio centrale dopo l’eiaculazione fu dedotta dalle registrazioni elettroencefalografiche (EEG) nei ratti, che mostrarono un’onda tipica di uno stato di riposo (onda lenta, a fusi, simile al sonno) per la maggior parte del periodo refrattario.
Durante questa fase assoluta, è stato inoltre scoperto che i ratti emettono un fischio ultrasonico continuo (22 kHz), che cessa nella fase refrattaria relativa. Segnali ultrasonici simili sono stati osservati in altre attività sociali e sembrano indicare un comportamento di cessazione del contatto. Ulteriori studi hanno evidenziato che la fase relativa del periodo refrattario è sensibile al testosterone, mentre la fase assoluta non lo è. Questo suggerisce un’evidente distinzione tra le due fasi del periodo refrattario post-eiaculatorio nei ratti, ipotizzando meccanismi separati (si vedrà più avanti il confronto con l’uomo).
Studi sul PERT nei ratti
Diversi studi sui ratti hanno indagato le possibili aree cerebrali coinvolte nel PERT, utilizzando lesioni cerebrali o metodi artificiali per stimolare l’eiaculazione. Barfield, Wilson e McDonald [1975] hanno eseguito lesioni nel mesencefalo rostrale che hanno abolito o ridotto drasticamente il PERT e le vocalizzazioni, senza tuttavia influenzare altri aspetti del comportamento copulatorio dei ratti. Gli autori hanno ipotizzato che le lesioni avessero interrotto i percorsi che collegano la parte ventrale del mesencefalo rostrale con l’ipotalamo posteriore.
Merari e Ginton [1975] hanno stimolato l’area preottica mediale (MPOA) tramite elettrodi, osservando un aumento dell’attività copulatoria e del numero di eiaculazioni, ma anche un significativo prolungamento del PERT.
Festival della Coppia - Relazione su Non Monogamia Etica
Questi risultati sono applicabili agli esseri umani?
È complesso valutare quanto questi risultati siano applicabili agli esseri umani, poiché le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno rivelato differenze nell’attivazione cerebrale durante l’eiaculazione tra ratti e uomini. Nei ratti, si osserva l’attivazione della MPOA, del letto della stria terminale e dell’amigdala, ma questi effetti non sono riscontrati negli uomini o nei primati [Holstege G et al. 2003]. Tuttavia, alcune di queste discrepanze potrebbero derivare da difficoltà tecniche legate alla risoluzione spaziale delle diverse metodologie di imaging cerebrale.
Sebbene non si sappia se i ratti sperimentino l’orgasmo, il fatto che l’eiaculazione sia necessaria per rafforzare le preferenze di luogo e partner suggerisce che essa sia piacevole. È comunque essenziale considerare le possibili differenze funzionali quando si confrontano i meccanismi cerebrali dell’eccitazione e dell’eiaculazione tra specie diverse.
Nonostante questa limitazione, alcuni aspetti generali della serie di studi classici condotti sui ratti da McIntosh e Barfield nel 1984, che hanno esplorato il coinvolgimento di tre vie neurali monoaminergiche (serotoninergica, noradrenergica e dopaminergica) nell’influenzare il Tempo Refrattario Post-Eiaculatorio (PERT), potrebbero essere applicabili anche agli esseri umani.
Il protocollo utilizzato nei tre studi era standardizzato e prevedeva:
(i) lesioni elettrolitiche in specifiche aree cerebrali;
(ii) uso di bloccanti specifici o neurotossine dei neurotrasmettitori, iniettati localmente o per via intraperitoneale.
Il primo studio esaminò il ruolo delle vie serotoninergiche nel PERT. Lesioni elettrolitiche del nucleo del rafe mesencefalico e iniezioni intraventricolari e intracerebrali di una tossina serotoninergica specifica (5,7-diidrossitriptamina), così come la somministrazione i.p. di p-clorofenilalanina (PCPA, un inibitore della sintesi della serotonina), ridussero significativamente la durata del PERT.
Nel secondo studio una tecnica simile fu utilizzata per valutare il ruolo delle vie dopaminergiche centrali. Lesioni selettive nella substantia nigra (principale sede della dopamina nel cervello) e l’iniezione locale di 6-OH-dopamina (una neurotossina specifica per le vie catecolaminergiche) determinarono un significativo aumento della durata del PERT. Anche la somministrazione di un bloccante dei recettori della dopamina (pimazolo) causò un incremento della durata del PERT.
Il terzo e ultimo studio esaminò il ruolo delle vie noradrenergiche (epinefriniche). Lesioni elettrolitiche del locus coeruleus e l’uso di inibitori della sintesi della noradrenalina (epinefrina) determinarono un prolungamento significativo del PERT, con un effetto particolarmente marcato nei trattamenti inibitori della sintesi della noradrenalina.
In sintesi, i risultati suggeriscono che l’attivazione delle vie dopaminergiche e noradrenergiche riduce la durata del PERT, mentre le vie serotoninergiche la aumentano. Negli esseri umani, infatti, i farmaci che aumentano i livelli di serotonina, come gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), sembrano ridurre la propensione all’eiaculazione e vengono utilizzati nel trattamento dell’eiaculazione precoce o prematura.
La rappresentazione grafica del ciclo di risposta sessuale maschile di Masters e Johnson è ancora considerata corretta?
Sono trascorsi ormai oltre 40 anni dalla pubblicazione di Human Sexual Response di Masters e Johnson, un’opera non sottoposta a revisione paritaria, che descriveva le fasi della risposta sessuale negli uomini e nelle donne. Gli autori elaborarono un modello testuale suddiviso in quattro fasi—eccitazione, plateau, orgasmo e risoluzione (modello EPOR)—e due modelli grafici distinti per il ciclo di risposta sessuale maschile e femminile.
Nel modello grafico maschile, l’asse verticale era chiamato “Eccitazione–Plateau–Orgasmo”, ma non venne mai specificato se rappresentasse l’eccitazione centrale, quella periferica o una combinazione di entrambe. L’asse orizzontale non aveva alcuna etichetta, ma dal testo si deduceva che rappresentasse la durata nel tempo (secondi, minuti o perfino ore!), anche se l’assenza di unità di misura influenzava la rappresentazione della durata dell’orgasmo e del periodo refrattario.
La prima risposta sessuale culminava nell’orgasmo con una fase ascendente (eccitazione), un plateau, un piccolo picco (orgasmo) e una fase discendente (risoluzione). Una linea grafica tratteggiata rappresentava una seconda risposta orgasmica, senza fase di plateau: l’eccitazione portava direttamente all’orgasmo. Dopo ogni orgasmo, delle parentesi verticali indicavano il periodo refrattario, dal momento successivo all’orgasmo fino a circa metà strada tra eccitazione e plateau.
Nel testo, il periodo refrattario era descritto come un “periodo refrattario sovrapposto, che può estendersi durante la fase involutiva fino a un livello inferiore di eccitazione. Un’efficace ri-stimolazione a livelli più alti di tensione sessuale è possibile solo alla fine di questo periodo refrattario”. Più avanti veniva specificato che il periodo refrattario “permane fino a quando la tensione sessuale nel maschio non è stata ridotta a livelli bassi di eccitazione”.
Tuttavia, essendo il periodo refrattario un intervallo di tempo in cui l’eccitazione sessuale non può indurre una risposta genitale, avrebbe dovuto essere rappresentato con parentesi orizzontali lungo l’asse del tempo e non lungo quello dell’eccitazione. L’errore di posizionamento verticale probabilmente derivava dall’idea, espressa nel testo, che il periodo refrattario si estendesse immediatamente dopo l’orgasmo a livelli inferiori di eccitazione. In realtà, le parentesi non arrivano nemmeno a toccare l’inizio della fase di eccitazione.
Sorprendentemente, questa figura originale è stata riprodotta innumerevoli volte senza subire critiche significative. In un articolo in cui l’autore descriveva la propria carriera nella fisiologia sessuale, egli riportò tre massime che avevano influenzato la sua filosofia di ricerca, tra cui: “Vedere ciò che tutti hanno visto, ma pensare ciò che nessuno ha pensato”. Inaspettatamente, questa riflessione si è rivelata applicabile anche alla rappresentazione grafica del periodo refrattario proposta da Masters e Johnson.
Sebbene questa critica possa essere considerata irrilevante, per maggiore accuratezza scientifica e comprensione, si suggerisce che il posizionamento delle parentesi debba essere corretto, ruotandole di 90° in senso orario affinché diventino orizzontali. Anche questa modifica, tuttavia, non corregge un altro difetto del modello originale: l’errore di scala nella rappresentazione della durata degli eventi sessuali.
Il picco orgasmico è un evento che dura al massimo circa 60 secondi, ma molto più probabilmente meno di 20 secondi, ed è rappresentato in modo sproporzionato rispetto alla durata del periodo refrattario, che nei giovani è misurato in minuti, mentre negli uomini più anziani può durare ore o persino un giorno. Questo problema è in parte inevitabile, poiché il modello grafico tenta di coprire una gamma di durate troppo ampia sulla stessa scala temporale. Un modo per correggere parzialmente questo errore è eliminare il tradizionale picco orgasmico e sostituirlo con un vertice orgasmico/eiaculatorio che ne sottolinei la breve durata.
Curiosamente, Masters e Johnson, lavorando in un’epoca precedente alla medicina basata sull’evidenza, non hanno mai pubblicato dati sperimentali a supporto del concetto di periodo refrattario negli uomini, né hanno citato prove derivate da studi sugli animali. Le loro affermazioni sull’esistenza del fenomeno oggi sarebbero considerate basate sull’autorità. Dati sperimentali quantitativi che dimostrano la presenza del periodo refrattario negli uomini e la sua possibile modificazione attraverso farmaci sono stati pubblicati solo più di 40 anni dopo.
Dr. Giuliana Proietti
Una presentazione sull'orgasmo femminile
Esiste un tempo refrattario relativo negli uomini dopo l’eiaculazione?
Un esame più dettagliato della figura di Masters e Johnson rivela altri due aspetti controversi. Il primo è semplice; è la rappresentazione grafica della cosiddetta “fase di plateau” come un’evidente linea orizzontale di attività da cui la fase orgasmica decolla come una distinta “gobba”. È difficile capire perché Masters e Johnson abbiano creato questa fase di plateau come un’entità separata. Ora è considerata una fase ridondante poiché, a differenza della bizzarra denominazione, l’eccitazione centrale e periferica che si verifica durante essa non raggiunge mai normalmente un plateau ma è in continuo aumento, portando infine all’orgasmo.
Robinson [1976] lo ha sottolineato e ora la maggior parte degli studiosi lo considera semplicemente come l’ultima parte della fase di eccitazione. Il secondo riguarda la natura del “periodo refrattario”. Nella loro figura, la seconda risposta di stimolazione rappresentata graficamente che porta all’eccitazione e a un successivo secondo orgasmo inizia esattamente alla fine del periodo refrattario delineato, ma, cosa interessante, non quando l'”eccitazione sessuale” sull’asse verticale è tornata a zero, bensì a metà strada tra le fasi di eccitazione e di plateau. Se, negli esseri umani, il periodo/tempo refrattario consiste in un “tempo refrattario assoluto”, quando è impossibile attivare un’erezione o un’eiaculazione, e un “tempo refrattario relativo”, quando diventa possibile indurre un’erezione aumentando lo stimolo sessuale applicando nuovi stimoli sessuali o un nuovo partner sessuale come precedentemente descritto dagli studi sugli animali, allora sono necessarie due rappresentazioni grafiche del tempo refrattario, una che mostra un’ulteriore eccitazione che si verifica immediatamente alla fine del “tempo refrattario assoluto” e una seconda che mostra la possibilità di una nuova eccitazione con maggiori stimoli sessuali all’inizio del “tempo refrattario relativo”.
Masters e Johnson non hanno mai affermato in modo categorico che ci fosse un “periodo refrattario relativo”, ma il fatto che abbiano descritto che il periodo refrattario sovrapposto era “mantenuto fino a quando la tensione sessuale non è stata ridotta a bassi livelli di risposta nella fase di eccitazione” suggerisce che si siano resi conto che un individuo poteva raggiungere un’altra erezione/eiaculazione durante i livelli più bassi dell’eccitazione sessuale calante e non dover aspettare fino alla completa dissipazione dell’eccitazione sessuale iniziale, vale a dire, un “periodo refrattario relativo” simile a quello del ratto. Tuttavia, non è stato esplicitamente affermato che questa risposta si verificava soprattutto se gli stimoli sessuali applicati erano nuovi o più forti rispetto a quelli utilizzati in precedenza (vedere la sezione precedente su PERT e l’effetto Coolidge).
Il PERT negli esseri umani è causato dal meccanismo dell’orgasmo o da quello dell’eiaculazione, o da entrambi?
Sebbene il periodo refrattario sia ora solitamente qualificato in relazione all’eiaculazione, un modello grafico corretto per l’eccitazione sessuale maschile umana deve mostrare la possibile suddivisione del Tempo Refrattario Post-Eiaculatorio (PERT) in una “fase refrattaria assoluta” e una “fase refrattaria relativa”. In questo scenario, l’eccitazione culminante in un secondo orgasmo/eiaculazione può avvenire prima, all’inizio della fase refrattaria relativa, senza dover attendere la fine completa della fase refrattaria, a condizione che lo stimolo sessuale sia “nuovo” o “più intenso” rispetto al precedente.
È importante distinguere se il fenomeno del PERT negli uomini sia causato dal meccanismo dell’eiaculazione in sé, da quello dell’orgasmo, o derivi dall’attivazione simultanea di entrambi. Non è noto se i ratti maschi sperimentino il fenomeno soggettivo dell’orgasmo, ma si sa che provano piacere gratificante durante l’eiaculazione (vedere la sezione sugli studi sul PERT nei ratti). Negli esseri umani, sebbene orgasmo ed eiaculazione coincidano quasi sempre, si riconosce ormai che sono mediati da meccanismi neurali indipendenti. Kinsey, Pomeroy e Martin furono i primi a fornire motivazioni a supporto di questa distinzione, mentre Levin ha aggiunto ulteriori prove alla loro indipendenza. Il luogo esatto in cui si genera il piacere dell’eiaculazione (orgasmo?) resta ancora un mistero.
Poiché alcuni uomini affermano di poter avere orgasmi multipli senza eiaculazione, questo suggerisce che sia più probabile che sia l’eiaculazione a determinare lo stato refrattario piuttosto che l’orgasmo. Tuttavia, esistono due casi documentati di uomini in grado di eiaculare più volte in un breve periodo. Kothari riferì di un uomo di 30 anni capace di controllare volontariamente i muscoli pelvici per eiaculare sei volte, espellendo piccole quantità di liquido seminale a ogni orgasmo. Whipple e Komisaruk descrissero invece un uomo di 36 anni che eiaculò sei volte in 36 minuti, con un primo volume eiaculatorio elevato e volumi successivi molto ridotti. Questi casi mostrano che alcuni uomini possono avere orgasmi ed eiaculazioni ripetute senza attraversare il PERT, ma non è chiaro quanto siano rappresentativi della popolazione generale, poiché non sono stati condotti esami cerebrali o neurali su di loro.
Bancroft menzionò casi clinici di giovani uomini con un livello di eccitazione sessuale estremamente alto che eiaculavano rapidamente con una minima sensazione orgasmica e con un’intensa e prolungata fase refrattaria, sebbene non siano stati forniti dettagli su questi casi.
Le donne hanno una eiaculazione?
Le donne sperimentano orgasmi ma generalmente non eiaculano liquido, sebbene alcune affermino di emettere un piccolo fluido uretrale (spesso chiamato “eiaculazione femminile” nella letteratura popolare), specialmente quando la parete anteriore della vagina (che include il complesso erotico del “punto G”, la fascia di Halban e l’uretra) viene stimolata con forte pressione digitale. Questo suggerisce che in alcune donne esista un meccanismo muscolare che, attraverso contrazioni pelviche, può determinare una forte espulsione di fluido durante l’orgasmo. Tuttavia, studi differenti non sempre hanno confermato la stessa origine di questo fluido. Inoltre, alcuni studi hanno trovato prove di un rilascio retrogrado nella vescica di una secrezione simile a quella prostatica durante l’orgasmo.
La mancanza di un’emissione esterna di fluido non implica necessariamente l’assenza di un’eiaculazione femminile, e nuovi studi sono necessari per determinare se le donne che mostrano questa attività sperimentino un periodo refrattario post-orgasmico.
In questo contesto, Belzer ha menzionato prove aneddotiche secondo cui tali espulsioni orgasmiche sarebbero seguite da un periodo refrattario simile a quello maschile. Anche Kothari suggerisce che le donne che eiaculano potrebbero avere un periodo refrattario analogo a quello degli uomini, citando Longo come fonte. Tuttavia, non esistono studi di laboratorio che abbiano confrontato donne che eiaculano e donne che non lo fanno, per verificare se le prime attraversino una fase in cui non desiderano stimolazione sessuale a causa di una temporanea non responsività (stato refrattario post-eiaculatorio).
 Dr. Giuliana Proietti
Dr. Giuliana Proietti
Psicoterapeuta Sessuologa
Il periodo refrattario post-orgasmico si verifica solo nei maschi?
Secondo Masters e Johnson, le donne non hanno un periodo refrattario post-orgasmico, poiché possono essere multi-orgasmiche in serie, ovvero sperimentare orgasmi ripetuti con pochissimo intervallo tra loro. Questi orgasmi sono solitamente indotti dalla masturbazione (sia autoindotta che da parte del partner), spesso tramite vibrazione clitoridea.
Diversi studi hanno riportato la presenza di orgasmi multipli seriali nelle donne, con alcune che ne hanno sperimentati più di 100 in una singola sessione. Tuttavia, pochissimi studi di laboratorio hanno registrato e pubblicato questi dati in modo dettagliato.
In che percentuale le donne sono multi-orgasmiche?
Non è noto quale percentuale della popolazione femminile sia multi-orgasmica; le stime variano molto tra gli studi:
– Masters e Johnson riportarono il 9%
– Kinsey et al. tra il 12 e il 14%
– Darling et al. il 50%
Questa grande variazione potrebbe dipendere da campioni di popolazione differenti o da selezioni specifiche.
Recentemente, Shtarkshall et al. hanno descritto una donna che afferma di poter raggiungere fino a 200 orgasmi seriali, spesso attraverso la masturbazione. Secondo la sua testimonianza, la stimolazione vaginale provoca l’emissione di grandi quantità di liquido, ma questa eiaculazione non sembra indurre un periodo refrattario. Tuttavia, si tratta di un singolo caso, e quindi non può essere considerato una prova scientifica verificabile.
Anche negli studi sui ratti femmina si sono osservate pochissime evidenze di un periodo refrattario femminile dopo il coito. Alcuni studi hanno trovato che, durante l’accoppiamento, le femmine attraversano un “periodo di quiete” dopo ogni eiaculazione maschile, della durata comparabile al PERT del maschio, probabilmente legato al trasporto degli spermatozoi all’interno della femmina. Tuttavia, ciò non ha un corrispettivo nel comportamento sessuale umano.
Cosa porta una donna a sentirsi sessualmente “soddisfatta” al punto da non voler continuare l’attività sessuale?
Davidson ipotizzò che questo potesse avvenire quando le contrazioni uterine all’orgasmo erano particolarmente intense, ma non esistono prove sperimentali a supporto di questa ipotesi.
Oltre alla semplice stanchezza fisica o al fastidio genitale derivante da stimolazione prolungata (ad esempio, vibrare il clitoride più di 100 volte!), il meccanismo che determina l’interruzione dell’eccitazione sessuale femminile rimane ancora sconosciuto.
Qual è il meccanismo del PERT negli uomini?
Esistono tre possibili sedi anatomiche in cui potrebbe avere origine il meccanismo del periodo refrattario post-eiaculatorio (PERT) negli uomini: il pene, il midollo spinale e il cervello. Tuttavia, è possibile che sia coinvolta una combinazione di tutti questi fattori. Come già accennato, gli studi sperimentali specificamente dedicati all’analisi dei meccanismi del PERT negli uomini sono pochi e si dividono in tre categorie: quelli che esaminano i meccanismi neurali, quelli che indagano i meccanismi ormonali e quelli che valutano interventi farmacologici.
– Indagini neurali
Solo tre studi hanno esaminato i possibili meccanismi neurali negli esseri umani. Yilmuz e Aksu (2009) hanno registrato i cambiamenti nell’attività del nervo dorsale penieno somatosensoriale in giovani uomini sani prima e dopo l’eiaculazione, riscontrando una piccola ma significativa diminuzione delle proprietà di conduzione. Sebbene abbiano ipotizzato che questo potesse ritardare l’erezione, non lo hanno considerato il meccanismo principale del PERT, suggerendo piuttosto l’esistenza di un meccanismo centrale a livello del sistema nervoso.
Uno studio sull’elettroencefalogramma (EEG) negli uomini dopo l’eiaculazione non ha mostrato schemi caratteristici di inibizione o stati di sonno, a differenza di quanto osservato nei ratti. Graber et al. (2009) hanno monitorato l’EEG durante la masturbazione e l’eiaculazione, senza trovare differenze significative prima e dopo, se non una lieve riduzione dell’attività alfa, generalmente associata a cambiamenti nell’attenzione e nell’eccitazione.
Uno studio di imaging cerebrale mediante risonanza magnetica funzionale (fMRI) ha mostrato che, dopo l’eiaculazione, le aree settali rimangono attive per un tempo più breve rispetto all’amigdala e al lobo temporale. Tuttavia, studi di tomografia a emissione di positroni (PET) condotti dal gruppo di Holstege hanno evidenziato che l’attività dell’amigdala e della corteccia entorinale adiacente viene inibita durante l’orgasmo. Non è stato possibile determinare quanto tempo questa inibizione persista, poiché la PET può catturare immagini solo per un massimo di 60 secondi. È stato ipotizzato che l’inibizione dell’amigdala durante l’orgasmo possa contribuire al PERT, analogamente a quanto accade in altri stati euforici, come l’uso di morfina e cocaina o l’innamoramento. Tuttavia, l’interpretazione delle immagini cerebrali in studi sulla sessualità presenta molte difficoltà metodologiche e non esiste ancora un consenso chiaro sulle aree attivate, disattivate o invariate durante l’orgasmo.
– Indagini ormonali
Il ruolo della prolattina è stato esaminato poiché livelli patologicamente elevati di questo ormone (iperprolattinemia) sono associati a un’inibizione dell’attività sessuale. Krüger et al. (2003) hanno ipotizzato che la prolattina rilasciata durante l’orgasmo potesse fungere da “interruttore” per disattivare l’eccitazione sessuale. Tuttavia, studi successivi hanno dimostrato che l’iperprolattinemia non riduce significativamente i parametri sessuali e che l’aumento fisiologico della prolattina post-orgasmo non inibisce la successiva eccitazione sessuale. Inoltre, è stato documentato il caso di un uomo capace di avere orgasmi multipli con un PERT molto breve (circa 3 minuti) senza alcuna produzione di prolattina dopo ogni orgasmo, suggerendo che la prolattina non sia il principale fattore coinvolto.
Si è anche ipotizzato un possibile ruolo dell’ossitocina, un ormone rilasciato durante l’eccitazione sessuale e l’orgasmo. Tuttavia, gli studi sui suoi livelli ematici hanno prodotto risultati contrastanti. Carmichael et al. (2009) hanno osservato un aumento dell’ossitocina sia negli uomini che nelle donne intorno al momento dell’orgasmo, mantenuto per circa 5 minuti. Krüger et al. (2009) hanno rilevato un aumento nei soggetti maschili, ma senza significatività statistica. Un’altra ricerca ha evidenziato un aumento dell’ossitocina durante l’eccitazione sessuale che persisteva dopo l’eiaculazione. Si è ipotizzato che l’ossitocina potesse inibire l’eccitazione sessuale agendo a livello cerebrale, ma una recente sperimentazione in doppio cieco con somministrazione intranasale di ossitocina non ha mostrato effetti significativi sul comportamento sessuale.
– Interventi farmacologici
Tre studi sperimentali hanno esaminato gli effetti del sildenafil (un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5) sul PERT. Due di essi hanno riportato una riduzione significativa del PERT senza alterare altri parametri della funzione erettile, mentre il terzo non ha riscontrato alcun effetto.
– Il primo studio (Aversa et al., 2009) ha utilizzato un protocollo con stimolazione visiva e una dose singola di 100 mg di sildenafil, trovando che il PERT medio nel gruppo placebo era di circa 10,8 minuti, mentre nel gruppo trattato era significativamente ridotto.
– Il secondo studio (Mondaini et al., 2009) ha utilizzato un protocollo con soggetti che assumevano 25 mg di sildenafil prima del rapporto sessuale con la loro partner e ha registrato una riduzione del PERT basandosi sull’autovalutazione della capacità di ottenere una seconda erezione.
– Il terzo studio (Ekmekçioğlu et al., 2009) ha impiegato un approccio più oggettivo con il dispositivo Rigiscan per misurare la rigidità erettile e non ha trovato alcuna riduzione del PERT con 50 mg di sildenafil.
È interessante notare che questi studi definiscono il PERT come il tempo necessario per ottenere una nuova erezione, ma l’erezione e l’eiaculazione sono meccanismi distinti. Pertanto, il PERT potrebbe variare se venisse misurato in base al tempo necessario per ottenere una seconda eiaculazione.
Qual è la funzione del PERT?
Non è possibile stabilire con certezza la funzione del PERT, ma si ritiene che sia più legata alla riproduzione che al piacere sessuale. Dopo l’eiaculazione, le riserve di spermatozoi si riducono, diminuendo il potenziale di fecondazione. Si stima che per ottenere una gravidanza siano necessari circa 60 milioni di spermatozoi per eiaculato, anche se sono stati registrati concepimenti con quantità minori. Poiché la produzione di spermatozoi avviene a un ritmo di circa 12,5 milioni all’ora, il tempo necessario per ricostituire una normale quantità di spermatozoi dopo un’eiaculazione varia tra 16 e 32 ore.
Tuttavia, i giovani uomini possono avere un PERT molto breve (circa 5-19 minuti), suggerendo che il suo scopo non sia solo quello di preservare le riserve di spermatozoi. Una teoria alternativa proposta da Gallup e Burch (2009) suggerisce che il PERT possa prevenire la rimozione dello sperma precedentemente eiaculato a causa della successiva penetrazione, garantendo una maggiore possibilità di fecondazione. Tuttavia, anche questa ipotesi sembra applicarsi più agli uomini maturi che ai giovani.
Il periodo refrattario femminile dopo l’orgasmo che funzione ha?
Bancroft [2009], come alcuni autori precedenti, ha ipotizzato che le donne possano effettivamente avere un periodo refrattario, ma che questo non sia evidente perché le persone studiate in laboratorio potrebbero appartenere a un sottogruppo che non manifesta questo comportamento. Tuttavia, non vi sono commenti né ipotesi su quale potrebbe essere la sua funzione nella donna.
Una possibilità, tenendo conto dell’ipotesi di Gallup e Burch [2004] riguardo alla funzione del periodo refrattario maschile (PERT) di ridurre lo spostamento del liquido seminale, è che anche nella donna questo servirebbe a diminuire il desiderio di un secondo rapporto sessuale subito dopo il primo, contribuendo così a conservare e proteggere lo sperma eiaculato già presente nella vagina, facilitando la possibile fecondazione.
Il periodo refrattario post-eiaculatorio (PERT) e la “sazietà sessuale” sono lo stesso meccanismo?
Kinsey et al. [1953] hanno affermato che “quando la capacità nervosa di un individuo è stata raggiunta, non vi è più interesse erotico e non si risponde più agli stimoli sessuali”. Questa osservazione sembra riferirsi più alla sazietà sessuale che al PERT.
Beach e Jordan [1956] hanno descritto l’esaurimento sessuale nei ratti maschi, che si manifesta quando essi hanno la possibilità di eiaculare ripetutamente con femmine ricettive. Anche Larsson [1956] ha pubblicato un’analisi dettagliata sul comportamento copulatorio dei ratti, includendo un capitolo su questo fenomeno. In questo contesto, il periodo refrattario è il risultato di eiaculazioni ripetute o multiple, mentre nel caso del PERT dopo l’eiaculazione si verifica un’unica eiaculazione. Una volta che un maschio raggiunge l’esaurimento sessuale, il recupero è lento e può richiedere tra i 6 e i 14 giorni nei ratti [2003].
Sebbene più eiaculazioni possano ridurre i fluidi genitali, è improbabile che questo sia il principale fattore che limita la performance sessuale. Infatti, studi su ratti sessualmente esperti hanno mostrato che la rimozione delle vescicole seminali, che contribuiscono in larga misura al volume del liquido seminale, non altera le prestazioni o la capacità di attività sessuale [1963]. Allo stesso modo, la rimozione delle vescicole seminali e della prostata non ha influenzato gli aspetti quantitativi o qualitativi della loro attività sessuale [1979].
Le prove sugli animali indicano che il PERT e la sazietà sessuale/esaurimento sessuale sono distinti sulla base di tre risultati sperimentali:
1) La somministrazione di bicucullina, un antagonista del GABA, accorcia il PERT nei ratti non saziati ma non ha questo effetto nei ratti saziati (potenzialmente a causa della competizione tra neurotrasmettitori) [2003].
2) La stimolazione elettrica dell’area preottica mediale (MPOA) accorcia il PERT, ma non influisce sulla sazietà sessuale [2003].
3) Sei giorni dopo la sazietà sessuale, il PERT assoluto (aPERT) torna alla normalità, mentre il PERT relativo (rPERT) rimane prolungato [1975].
Altri studi hanno suggerito che la sazietà sessuale provoca una drastica riduzione dei recettori per gli androgeni nell’area MPOA, pur mantenendo i livelli plasmatici di androgeni, indicando che la diminuzione dei recettori potrebbe contribuire alla sazietà [2003].
Il PERT può dipendere dall’età?
La dipendenza del PERT dall’età è evidente nei giovani e negli anziani. Kinsey et al. [1948] hanno riportato che alcuni ragazzi preadolescenti (dati controversi nei loro studi) erano capaci di orgasmi multipli con un periodo refrattario minimo o nullo. Con la pubertà, il PERT si sviluppa, suggerendo un ruolo degli androgeni [2009].
Masters e Johnson [1966] hanno accennato alla dipendenza del PERT dall’età nel maschio anziano in una sola frase: “Ci sono due principali differenze tra il maschio giovane e quello anziano durante il periodo refrattario della fase di risoluzione:
(i) il periodo refrattario si prolunga con l’invecchiamento, in particolare dopo i 60 anni; (ii) la detumescenza peniena dopo l’eiaculazione è così rapida che le due fasi caratteristiche nei giovani uomini non si distinguono più”.
Tuttavia, non hanno fornito dati a supporto di questa affermazione.
Newman [1984] ha sostenuto che vi è un brusco aumento del PERT dopo i 50 anni. Molti altri autori hanno scritto che il PERT dipende dall’età senza fornire prove oggettive. Nonostante questa convinzione diffusa, è difficile trovare evidenze sperimentali specifiche a supporto di questa conclusione.
Uno studio di Ekmekçioğlu et al. [1993] ha misurato il PERT in giovani uomini (età media di 26 anni, intervallo 19–42, N = 22) trovando un valore medio di 19 minuti (intervallo 5–52 minuti). Tuttavia, non esistono dati sull’invecchiamento e il possibile periodo refrattario post-orgasmico nelle donne.
Il PERT influenza il condizionamento sessuale?
Un’idea interessante è che il condizionamento sessuale nella fase precedente all’orgasmo (la cosiddetta fase del Plateau) potrebbe essere più efficace rispetto al periodo post-orgasmico, durante il PERT. Kantorowitz [1978] ha studiato questo fenomeno in un esperimento ben controllato con giovani maschi eterosessuali.
Ai partecipanti è stato chiesto di imparare a prevedere con precisione l’eiaculazione due minuti prima che avvenisse, durante la fase del Plateau del modello di Masters e Johnson (oggi riconosciuta come parte della fase di Eccitazione). Dopo l’eiaculazione iniziava il periodo refrattario. L’eccitazione sessuale dei partecipanti è stata valutata tramite una misurazione della tumescenza peniena con un sensore di tensione alla base del pene.
I risultati hanno mostrato che il condizionamento a immagini statiche di donne nude era più efficace durante la fase del Plateau rispetto al periodo refrattario, in cui l’efficacia diminuiva significativamente. Kantorowitz ha suggerito che questi risultati potrebbero avere implicazioni cliniche nella desensibilizzazione di comportamenti sessuali inappropriati.
Secondo il modello di PERT assoluto e relativo, questo studio potrebbe essere utile per comprendere se il periodo refrattario abbia una fase assoluta e una relativa, in cui il condizionamento possa essere più o meno efficace.
Periodo refrattario secondario o inverso negli anziani: di cosa si tratta?
Masters e Johnson [1966] hanno riportato un fenomeno insolito negli uomini anziani: “Quando un maschio di oltre 60 anni raggiunge una piena erezione e poi la perde senza eiaculare, può incontrare difficoltà nel recuperare la capacità erettile. Gli uomini più anziani possono reagire alla perdita dell’erezione senza eiaculazione con quello che potremmo definire un periodo refrattario secondario”.
Non viene indicata la percentuale di uomini anziani che sperimentano questo fenomeno, né se stimoli sessuali più intensi o nuovi possano superare questa inibizione, come nel cosiddetto effetto Coolidge. Non sembrano esserci altre segnalazioni nella letteratura scientifica su questo tipo di periodo refrattario anomalo.
Tomografia Elettromagnetica Cerebrale a Bassa Risoluzione (LORETA): di cosa si tratta?
Un nuovo e interessante approccio per esplorare il PERT umano è l’applicazione di una tecnica che registra l’attività elettrica del cervello tramite EEG digitale, generando un’immagine tridimensionale funzionale dell’attività elettrica. Questo metodo permette di localizzare le fonti di attività cerebrale attraverso la ricostruzione della densità di corrente, identificando i gruppi neuronali attivi.
Questa tecnica, chiamata “LORETA” (Low-Resolution Brain Electromagnetic Tomography), è stata introdotta per la prima volta nel 1994 da Pascual-Marqui, Michel e Lehman. Recentemente, Hyun e collaboratori l’hanno utilizzata per indagare i cambiamenti nell’attività cerebrale tra soggetti con eiaculazione precoce e soggetti di controllo mentre guardavano video erotici. Tale tecnica potrebbe essere facilmente applicata al monitoraggio dell’attività elettrica cerebrale negli uomini prima e dopo l’eiaculazione.
Festival della Coppia - Relazione su Innamoramento
Dr. Giuliana Proietti
Psicoterapeuta Sessuologa
Ancona, Civitanova Marche, Fabriano, Terni, Online
Costo Terapia 90 in presenza, 60 online
Quali sono le conclusioni di questo studio?
Dalla letteratura esaminata emergono le seguenti conclusioni, alcune più certe di altre:
1. Nei ratti il periodo refrattario si verifica dopo una singola eiaculazione. Durante il PERT, ulteriori erezioni ed eiaculazioni sono inibite.
2. Masters e Johnson hanno descritto per primi questo fenomeno negli uomini, ma lo hanno delineato in modo inaccurato nel loro modello grafico della risposta sessuale maschile. L’eiaculazione umana e l’orgasmo, che di solito la accompagna, sono regolati da meccanismi separati. Il PERT sembra essere legato più all’eiaculazione che all’orgasmo. Inoltre, è descritto come dipendente dall’età: nei giovani può essere breve (misurabile in minuti), mentre negli uomini più anziani può durare fino a 24 ore o più.
3. Nei ratti femmina è stata trovata un’evidenza limitata di un “periodo di quiescenza” dopo il coito, mentre nei soggetti che potevano “regolare il ritmo” del rapporto sessuale è stato osservato un periodo refrattario, influenzato dal numero di intromissioni del maschio. Tuttavia, nell’essere umano non esistono prove sperimentali solide di un PERT femminile. Alcuni autori ipotizzano la sua esistenza, soprattutto dopo l’eiaculazione femminile o potenti contrazioni uterine orgasmiche, ma non vi sono misurazioni o studi specifici.
4. Negli studi sui roditori, il PERT sembra avere due fasi:
– aPERT (assoluto), durante il quale nessuno stimolo sessuale può attivare un’erezione o un’eiaculazione;
– rPERT (relativo), durante il quale uno stimolo più forte o nuovo può indurre un’erezione.
Nei ratti, l’aPERT è caratterizzato da vocalizzazioni ultrasoniche a 22 Hz, che segnalano “cessa il contatto”.
5. Negli uomini non è stato formalmente descritto un periodo refrattario relativo (rPERT). Non vi sono prove sperimentali dirette a supporto della sua esistenza, ma gli studi sugli animali ne suggeriscono la plausibilità.
Relazione su Sessualità e Terza Età 14-09-2024
Dr. Giuliana Proietti
Ancona, Civitanova Marche, Fabriano, Terni, Online
Tel. 347 0375949
6. Non è ancora chiaro dove sia localizzato il meccanismo del PERT nell’uomo (cervello, midollo spinale o pene). Studi neurologici hanno rilevato una riduzione della funzione del nervo dorsale del pene e un’inibizione dell’attività dell’amigdala durante l’orgasmo. Le ricerche ormonali hanno escluso un ruolo predominante della prolattina, mentre l’ossitocina rimane un fattore poco esplorato. Negli studi sui ratti, le vie della noradrenalina e della dopamina sembrano ridursi, mentre quelle della serotonina si allungano durante il PERT. Infatti, gli agenti che aumentano i livelli di serotonina nel cervello riducono la propensione a sperimentare eiaculazione precoce negli uomini.
7. L’ipotesi che il PERT nei maschi abbia la funzione di conservare gli spermatozoi per massimizzare le opportunità riproduttive sembra improbabile. Il tempo stimato per il rimpiazzo degli spermatozoi dopo un’eiaculazione è di circa 16-32 ore, mentre molti giovani possono eiaculare nuovamente in meno di 20 minuti.
8. L'”Effetto Coolidge” nei ratti descrive il ripristino dell’interesse sessuale in un maschio apparentemente sazio quando gli viene presentata una nuova femmina recettiva. Non è possibile dimostrarlo sperimentalmente negli esseri umani per motivi etici e sociali, ma alcuni comportamenti maschili suggeriscono elementi di questo fenomeno:
– riduzione dell’attività sessuale con la stessa partner dopo i primi due anni di matrimonio;
– assuefazione agli stimoli sessuali visivi in laboratorio;
– maggiore interesse degli uomini, rispetto alle donne, per la varietà di partner sessuali;
– preferenza maschile per volti femminili nuovi rispetto a quelli familiari, mentre le donne tendono a preferire i volti noti.
9. Sono necessarie indagini critiche sul PERT negli esseri umani attraverso tecniche di neuroimaging ed elettrotomografia cerebrale, ma tali studi non sono ancora stati realizzati.
Adattato da
Revisiting Post-Ejaculation Refractory Time—What We Know and
What We Do Not Know in Males and in Femalesjsm_1350 2376..2389
Roy J. Levin, MSc, PhD
Sexual Physiology Laboratory—Porterbrook Clinic, Sheffield, UK
DOI: 10.1111/j.1743-6109.2009.01350.x
Dr. Giuliana Proietti

Dr. Giuliana Proietti
Psicoterapeuta Sessuologa
Tel. 347 0375949
Ancona, Civitanova Marche, Fabriano, Terni, Online
Immagine
Foto di Andrea Piacquadio

Psicologa Psicoterapeuta Sessuologa
ANCONA FABRIANO CIVITANOVA MARCHE TERNI e ONLINE
● Attività libero professionale, prevalentemente online
● Saggista e Blogger
● Collaborazioni professionali ed elaborazione di test per quotidiani e periodici a diffusione nazionale
● Conduzione seminari di sviluppo personale
● Attività di formazione ed alta formazione presso Enti privati e pubblici
● Co-fondatrice dei Siti www.psicolinea.it, www.clinicadellacoppia.it, www.clinicadellatimidezza.it e delle attività loro collegate, sul trattamento dell’ansia, della timidezza e delle fobie sociali e del loro legame con la sessualità.
Sito personale: www.giulianaproietti.it